➶
(NOTE SUL MISTERO DELL'ARCHITETTURA INTERNA
Una miriade di volatili posati sul nulla,
leggeri come
ossa cave,
attenti come
famelici schianti.
Ogni piuma sottile sfiora le narici degli istanti,
e volando via,
rientra nel
vivente aperto
il sospiro della sua fuga.
Una miriade di pensieri lunghi,
come
l’orizzonte che mai tace,
che sempre muta,
come il dio muta,
nella sua orbita eterna e fugace,
il dio muta.
Comincio a sentire
una storia
che timidamente
emerge
come il frutto più recente
dei
dolori più antichi.
Il cuore, un residuo alto
delle interiora,
una briciola caduca del pensiero
si contrae sul pavimento della cassa toracica,
piuma e radice,
chiedendo più luce, cercando più luce.
E subito dopo può esserci solo un battito che si dimena,
ad irradiare la sua gabbia.
Lì, a raccogliere quel muscolo inquieto e sanguigno,
un dubbioso impavido macigno.
Mai si stanca quel
percussionista disinteressato
di
tagliare l'oscurità, attraversandola,
perdendola, e rincontrandola un’altra volta.
Mai si dimentica,
agitato e quasi pietra.
Buonasera elegante lucertola,
riconoscerei i tuoi occhi tra mille,
ma i miei non li ho mai visti.)
➶
(IL VIVENTE
L’evoluzione in una certa maniera, scardina i valori dei popoli.
Siamo giunti sull'orlo di un'altra civiltà.
Ci affacciamo sicuri sul bordo del vuoto, attenti a non vacillare per la grande inerzia.
Se l'orizzonte fosse verticale, come su Saturno, chissà dove avremmo gli occhi.
E, se il caldo diventasse insopportabile, l’unico che vorremmo conoscere allora sarebbe il rettile.
Seguiremo affamati le sue regole di sopravvivenza,
assorbendo movimento dal sole.
Rimarremo fermi ad aspettare la fame, inalando umidità per contrastare la sete.
Ci muoveremo lentamente, incantati dalla fata morgana,
c'è una fonte laggiù.
C'è una fonte laggiù.
E i rettili crescono, a volte ci mangiamo, velocissimi, per poi rimanere fermi, ad
aspettare la fame.
Ci avviciniamo piano a ciò che pare uno specchio. Ci abbaglia, ci teme.
La bocca si schiude, arida e leggera.
Una goccia d'acqua.
Una goccia d’acqua si bagna di polvere, e guarda lontano.
Per un altro giorno.
Il grande specchio giace languido nella luce e nell’ombra.
Pare non esservi questione sull’unità del vivente, anche, e soprattutto, quando lo specchio è lontano.
Bentornato, dinosauro.
Sei ben cresciuto dall'ultima volta che ci siamo visti alla sorgente.
Io ho perso tutte le squame, tutte le spine, tutte le unghie, i peli, i canini, le zanne e le piume.
Sono rimasto
solo pelle e impulso.
Come una manta.
Mi correggo su due esili impronte, per la maggior parte delle volte poco durature.
Ho lunghe braccia per fare, ma ho perso la coda.
Ora vado solo avanti.
Il mio scheletro è una catena di eventi, il mio sangue
un evento a catena.
Divoro ossigeno e
nasco per espellere veleno.
Mi sembra di essere seduto dietro agli occhi, finché distratto talvolta inciampo e vedo tutte le mie biglie rotolare.
Cerco acqua, come te.
Oggi lo specchio sembra molto piccolo, ma
tu riesci a vederti?
Sei ben cresciuto dall' ultima volta che ci siamo visti alla sorgente.
Cosa ho fatto in tutto questo tempo?
Ho bevuto, ho bevuto ogni cosa.
Sono affetto da infodemia.
Cerco le mie tracce in
una città in continua costruzione, anelo la polvere
per poterla scostare con un dito.
So modellare gli specchi. Ho imparato da mio nonno.
Sì ho ancora un cuore, sempre più in centro al petto.
Talvolta impregna lo sterno di adrenalina, ed è un piacere.
No, non mi fermo tanto,
devo andare avanti, sempre avanti.
Tu? Ah, sei appena arrivato, ottimo, ottimo.
Continua pure ad essere alto, a me piace essere minuto, vederti da quaggiù,
o da quassù, in questo mondo
tondo, semplice e loquace.)
➶
(PELLE
Il perimetro che più sfida la geometria.
Osmotico, caldo e aperto.
La divisione è un’umana decisione.
Il confine e l’indipendenza, un’antica questione anarchica.
La pelle.
Ed è da questo
territorio mobile e centrato che il rettile respira.
Respira.
Respira.
Veloce, freddo e corazzato. Respira.
Equilibrista nato, il vivente nasce infilato da un peso invisibile, con la testa tra le nuvole.
In giovane età solleva i passi, espirando l’invisibile.
Una geometria empirica, strategica, tragica e docile, come ogni passo.
Il gran regista, luminosa, alto, dirige silente ed inesorabile le sue biglie irrequiete.
Domandole, come orbite.
Gioca, sperando un giorno di inciampare e vedere, tutto ad un tratto,
tutte le sue biglie rotolare.
Bestie attaccate al peso invisibile come moschini verso la luce dell'ardente candela.
Brucia!
Si alza stordito e spegne la candela con uno straccio.
Il fumo dell'ultima traccia. L'unità si chiude.
Guardiamo lontano e ci vediamo le spalle.
Sottopelle,
un
intricato sistema di strade scorre indisturbato, trasferendo messaggi elettrici in corsa.
In questo
fiume ad alto voltaggio, vi sono alcuni rari e precisi accessi, colorati di un dolore aperto.
Questi punti aprono le loro fauci affamate, ed in questi punti entrano sottilissime spade, che elettriche diventano direzione, calore, sciolgono rancori, ansie, e forti impatti.
Trasportano quanti luminosi, sì,
la particella complessa, l’ultima e la prima, dipende da dove guardi.
I punti, come aghi tra il reale e l’anatomia sottile, sono cancelli per le milizie pacifiste dei biofotoni,
che trasportano informazioni in codice come una radiotrasmittente in movimento.
E’ un grande mistero, come questo confine osmotico si stenda nel tutto, ne riceva le voci, ne riveli di interne, respiri d’anima propria.
Si rinnova come un serpente.
Vi è un momento in cui all’ambiguo rettile sibilante, durante la muta, si seccano anche le palpebre.
E, per un momento lungo un’eternità, diventa cieco. I predatori lo sanno bene.
L’aquila sbatte,
silenziosa e lontana, la palpebra nittitante.
Con nuove brillanti cornee, il serpente comincia a farci strada, in quello che sembrava un tunnel roseo, morbido ed in iperattività.
Colonie di microbi chiacchierano in ogni angolo,
Mimetizzandosi con le spade anche le zanzare, succulente ormai, se ne vanno svolacchiando e sbandando, con le pance piene.
Mentre camminiamo si sente
un sibilo strano, come un sistema di ventilazione in costante misura.
Entra ed esce un’aria viva, quasi della stessa temperatura, fredda, poi più umida, poi vira all’aria asciutta, ..
non vediamo più il serpente.
Siamo dentro di lui.
Ci ha ingoiati.
E siamo
nel bel mezzo del suo ventre, sbandati qui e là dai suoi movimenti sinuosi.
Ad un tratto forse una spina, uno spavento, l’istinto della fame.
La bestia
si contrae all’improvviso, rapida ed incosciente, come bruciata.
La membrana che respira sembra avvicinarsi a noi, sempre più, fino a sfiorarci la pelle, sempre più aderente.
Incorporati.
Sono il serpente.
E come il dio, muto, inesorabilmente muto.)
➶
(NERVI
Ero un calore nervoso
una mossa ferma.
La
tensione di una forza senza resistenza
un fascio di strade
tese, nervose, che mi ingabbiavano l’addome
Il ritmo.
Vibravano in silenzio,
vagavano in un
mutismo fatto a pezzi,
un ritmo lento ed uniforme, come il centro di una spina.
Letale e vivace come la punta di una spina,
che ha due volti,
come le radici di un albero, come il verso del sangue,
come la fine di un cielo.
Ero un calore nervoso, che mi muoveva da dentro
come un serpente di fuoco
una
gelida danza senza uscite,
mi abitavo,
mi abitavo.
Dormivo nel mio stesso grembo, urlavo
nel mio stesso cranio,
un respiro all’indentro
nervose le spine del tatto
fino alle spiagge della pelle.
Nuotavano tra le costole i serpenti,
intriganti, eravamo due, ed ero io sola, ero calore,
faceva freddo.
Lì dentro non sembrano occhi, perché non è mai buio ma c’è un segreto, l’ombra del mistero antico,
che mi mette scomoda,
mentre lo contengo, lo agito, mi pare di controllarlo,
senza di lui non
esisto.
Una materia che vibra
eppure scorre indisturbata,
magari corre un po’ più veloce quando
in un silenzio caldo,
va da tutte le parti.
Mi punge la gola, la spina dell’orgoglio,
lì sì che eravamo due teste,
un duello teso,
dritto verticale, senza sommità altra
che il nostro duello.
Un calore nervoso, lo ero, lo sono, ma lo ero prima di esserlo.
La spina nel fianco di un’idea, che poi diviene, è,
costruisce si specchia,
si prega, si annienta, e
torna cenere,
sempre calda, sempre nervosa,
da cui sorge il tempio, in cui vive il tempo, unico.
Coda e capo, che dorme nel mio ventre,
ed io entro nel suo ventre, mi faccio muscolo, arteria, lo prego, lo vedo, lo imito, lo stanco.
Ma rimango una spina nel suo fianco, ciò lo rende nervoso,
letale e vivace,
l’ombra del tempo,
è il su stesso scorrere, la lacrima di vetro che non trova gravità, e grave dondola.
Sul fuoco,
cerca la sabbia cerca il rintocco,
cerca ancora la resistenza,
e mi ritorna dentro, luce avida ed infuocata, vi ritroviamo nella testa,
scendiamo la scala d’oro, e ci arrendiamo nelle coste.
Mi guardo intorno e sono sola di nuovo, la pelle è calda
sotto qualcosa si muove, mi punge, mi muove
nervosa sapevo nervosa mi muovevo.
Mi addormento e di nuovo riappare lui,
il serpente, gli occhi, rubini, vulcani, punte di sangue vivo,
lo guardo e mi guardo sua figlia e sua madre lo tocco e mi tocca,
lo tocco e mi brucio, mi tocca e si brucia.
Brucio gelata.
Gelati dall’essere veri ci addormentiamo sul torace di un dio di pietra
che fresco e calmo ci insegna
l’altro tempo,
e lui ne ha visti tanti, e lui li è tutti
mi guardo e sono il serpente in cammino, il serpente nel tempo
lo ero già prima di esserlo, già lo ero, prima di tutto,
ero un calore nervoso.
Semplicemente
una spina d’oro nel fianco del tempo.)
➶
(IPNOGRAMMA
Il cammino del rettile è tortuoso.
I migliori ragni si nascondono tra le spine, molto vicini alle loro prede.
Le spine nascondono sorridenti un potente veleno.
Possono vedere e non essere viste.
Manifestarsi nel sole e
cercare l'ombra.
Come l'elettricità.
Il vivente, percorso d’alto voltaggio, è nondimeno fatto di acqua.
E per di più, non solo il corto circuito è altamente possibile, ma anche
frequente.
Di una frequenza in
costante allerta, ed abbandonata alle mani degli dei.
Il corto circuito connette di fatto le mani della macchina.
Crea lavoro per
tutta la macchina, che solo così, esiste.
Quella leggera pausa che consente al sangue di entrare nel cuore è creata dal punto nervoso che incontra il nervo vago.
Una bella coppia.
Teste alte, astratte.
L'uno si trova spesso davanti ad uno scuro portone di legno, mentre l'altro, il nervo vago,
cammina elegante per la città.
Quando si incontrano, con grande frequenza per l’appunto, il punto nervoso tende la mano velocemente, puntuale e forte.
Così il nervo vago, con gran classe, gliela stringe.
Sì ferma tutto, ogni
valvola, per un istante.
Stante.
(Nel frattempo il sangue, un tipo fluido e disinteressato, dritto si affaccia nel cuore… ).
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
DRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNN
LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB -
LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB -
LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB -
LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB - LUBDUB LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB – LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB
DUB –
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB – LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB -
LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB DUB - LUB
DUB - LUB
DUB –
LUB DUB -
LUB>
DUB –
LUB DUB –
LUB DUB - LUB
DUB –)
➶
(IL CUORE
Lounge bar.
L'entrata vira subito dopo aver varcato la soglia. Un corridoio scarlatto, velluto rosso e legno scuro. Non si vedono i pavimenti, la luce è alta, lontana, stretta, fioca e lunga, sopra ai capi.
Ti ho visto già due volte, pantera chiara. Ti muovi come un felino sazio, attento e sicuro, piano, stai, sorvegli.
La tua posizione
si irradia come un'ombra, potente e circolare, occupa lo spazio.
Gli occhi presenti, stai, pensi.
Ti muovi come un vivente che ha camminato tanto, e sa quando star fermo.
Ti giri lentamente perché già sai cosa stai per vedere, dai il tempo di essere visto, non guardi mai due volte.
Porti il tuo mistero all'aria fresca, limpido e selvatico.
Nessuno sa da dove arrivi.
Quando entriamo, .. Quando entriamo?
E mentre ti vedo, anche io mi muovo, un felino alto, acceso, in lenta digestione, cammino, ogni volta che ti vedo cammino, e non ci fermiamo mai.
Tu fermo, scompari come mi sei apparso, mi sorprendi mentre già scompari.
Il soffitto è curvo,
un arco allungato in avanti, una curva morbida, avvolgente.
Quando finisce il corridoio le spalle sono più basse e il collo più lungo.
La gola si porge in avanti, morbida, imperterrita e disinvolta, pronta a tacere.
Lo sguardo orizzontale, la luce è rossa, calda, brace.
Affumicato il suono della radio si fa strada tra i divani di pelle, le sedie di vimini, i cuscini color petrolio.
Canta una voce profonda, una caverna in danza, leggera, forse
la porta di un lago nascosto.
Non si vede il pavimento, si sente che è di legno, a grandi masselli.
Il velluto chiaro, color senape, avvolge gli sgabelli di ferro battuto girevole, davanti al banco.
Le luci, qui, sono verdi, bottiglie di vetro spesse che proiettano sul bancone cerchi d'oro,
nitidi proiettori di
fumo e polvere.
Vesti anche tu di scuro, una lana leggera, un po’consumata sui gomiti, a fior di pelle.
I pantaloni morbidi coprono le gambe magre e quel passo,
la savana e la foresta, smeraldo iridescente, un
miraggio cosciente.
Selvatico, pericoloso.
Limpido, letale, risplendi elegante tra le bestie del porto.
Questo angolo di città dove il fiume soffia nel mare, dove lo iodio sa di muschio,
l'orizzonte una laguna aperta, che vira, subito prima di varcare la soglia.
Qui entriamo nell'attesa, calmi.
Al bancone si riposano molte stoffe, pensierose e fumanti, piegate in diversi modi, chi con il ginocchio alzato, chi con i piedi incrociati dietro, chi accavalla le cosce, e chi sta in piedi, perché dopo questo vado.
Le spalle larghe, i cappotti slacciati, i cuori appartati, i capelli scompigliati dal vento, oggi c'è tanto vento, caldo e
argenteo.
La luna è una lamina, un'iride, stanotte. L'unica finestra nel bar è uno squarcio di cielo nel soffitto, un'enorme specchio nero sul cielo. Tra poco arriverà', con la sua giacca di pelle, pallida con gli occhi orizzontali,
apparirà nella finestra nera, e come un diamante passerà a cantarci un'altra storia aguzza, una rima d’avorio, incantata dalla tua danza lenta, continua e languida, il lamento silenzioso di
un rapace in volo.
Il tuo elegante mistero si appoggia allo schienale del divano, il tavolino di vetro alle tue ginocchia nodose, poco sotto, ti attende con un calice opaco, spesso, colmo di un sangue di uve invecchiate in botti fumose,
dolci e amare.
Non guardi nessuno, vedi tutti. Abbondi, non abbai mai, raramente parli. Anche tu sai che mi devi incontrare, anche tu non hai fretta, anche tu misuri, anche tu lo sai.
Attenti misuriamo insieme le distanze, la tensione più sensuale, in questa notte sveglia.
E chi comincia?
È tutto silenzioso. Entra, sembra non esserci nessuno. Sì accomoda in fondo, spalle al muro, solito posto.
Ma non appena si siede sul divano di velluto rosso,
sente sotto di sé un fascio di muscoli contrarsi e subito vola alto, circolando nel suo stesso peso.
Orbita in una precisa direzione,
un fluido elastico, il futuro spinge sugli occhi.
Se non che, ad un tratto, si ritrova in uno strano edificio.)
➶
(I POLMONI
L’albergo è una struttura poliedrica e ferma, avvolta nella polvere.
Ha le facciate rosa pallido ed uno spesso muro che lo circonda.
Piccoli alberi anche essi avvolti nella polvere crescono verso il sole forti, e sono stati piantati tra le corse delle iguane.
Colorate, velocissime.
L' albergo è vicino al fiume, e l'acqua potabile ed in corsa che si scorge tra gli alberi è dello stesso colore delle iguane.
Un serpente sinuoso,
verde terra, verde acqua, verde aria e verde fuoco.
Un Dio che bagna le labbra alla città che attraversa, con le tasche piene di pesci, e le
braccia avvolte dal riso, un grano piccolo e morbido, che ha il colore degli occhi dei pesci.
Entrando dalla vigilante porta di ferro, dipinta di un blu pesante, sul lato del fiume, vediamo chiaramente che il tempo non esiste più, da lì in poi, da lì in avanti, non esiste più.
Il tempo nuovo è qui composto da
spazi lunghi un respiro,
stanze in cui lentamente si entra e lentamente si esce.
Si cerca il vento nei lunghi passi.
Al centro della vecchia struttura alberghiera circondata da stanze
aggrappate all'ombra soffocante
c'è una piscina di pietra, abbandonata, languida, sotto i petali di ibisco rosa, che perduto il loro ramo tentano di rifiorire nelle loro origini.
Ogni stanza ha una forma diversa, in cui non esiste un angolo uguale all’altro
Anche i soffitti sembrano
perimetri diversi dai pavimenti.
Ventilatori di dura plastica giallina sono attaccati ai loro cieli con forza, pronti a lanciare polvere in forme circolare, quasi ancestrali, sui pavimenti di piastrelle colore senape.
Ogni stanza raggruppa il suo
centro in luoghi insoliti.
Ed è qui che silenziosamente e lentamente gli ospiti dell’albergo organizzano la rivoluzione.
Il poliedro rosa è il vero covo delle informazioni.
Una stazione
radio inesorabilmente attiva.
Raccoglie il veleno respira ossigeno raccoglie il veleno respira ossigeno, espira il veleno divora ossigeno, espira il veleno, è ossigeno.
Il fiato come l’acqua.
Come iguane all'ombra gli ospiti progettano da tempo cosa fare per prendere il controllo della grande cisterna, a nord del fiume.
La missione non è semplice.
La cisterna è controllata da un dio invisibile.
Un dio fatto da
una sostanza che nessuno conosce.
Un dio minerale,
chimico, etereo.
Il dio nacque dalle mani di un dio ancora più grande.
Un fiume di polvere e sabbia che vagava per l'universo cercando di mettere in ordine i due poli di ogni cosa.
Ma da solo non riusciva sempre ad aggiustare un polo e l'altro lo imitava, creando un corto circuito di equilibri
asimmetrici ed identici.
Decise allora di creare dalle sue mani un dio invisibile, mai rintracciabile, cosicché la mimesi fosse impossibile e lasciasse il posto al sacro
ordine degli opposti.
La necessaria elezione con l'altro.
Fu così che il grande dio iniziò ad organizzare le sue sabbia in mille soli, distribuiti in modo geometrico, creando
l’impressione di uno spazio di mille miliardi di miliardi di specchi..)
➶
(IL CERVELLO
Viaggiamo veloci.
180 km / h finestrini aperti.
100 m / s alta l’impulso, l’informazione.
Viaggiamo rapidi.
Ai lati, alberi a non finire, in lungo ed in largo, si ramificano in un cielo incorniciato, dentro e sopra.
Passano veloci i filari, assordanti, fertili.
Davanti le chiome che si incontrano disegnano un cielo in mutamento, quasi un’ombra luminosa, definita dalle cime cangianti degli alberi.
Un tunnel aperto, infinito, che cambia velocissimo.
Il vento entra dai finestrini rombando, assordante e bianco, crea il vuoto urlando.
Noi seri guardiamo dritti, appostati.
Velocissimi.
Le quattro ruote sfrecciano incoscienti e sicure, la mente è altrove, la strada unica.
Corriamo nel nostro lungo istante,
nessun freno, tranquilli.
Lentamente la strada si arresta,
entriamo in curve diritte, univoche,
ma andiamo dritti, continuiamo ad andare dritti.
Avanti, sempre avanti.
Caverne termitiche, un territorio fatto di cunicoli, torniamo sempre allo sesso punto.
Siamo qui ancora, di nuovo, ecco, siamo arrivati.
Continuiamo a correre, una sigaretta, due..
sono appoggiata dietro al tuo capo che guida, i tuoi capelli mi suonano le dita,
ma non credo tu lo senta, sono tentacoli che si dimenano, e io dentro al tuo passarmi affianco.
Mentre corriamo, sbatto gli occhi un attimo, il vento mi ha asciugato le palpebre.
Lentamente le chiudo e le riapro, un istante, un’ora, un’epoca.
Quando spalanco gli occhi siamo di nuovo sulla strada maestra.
Gli alberi non ci sono più,
sono linee di luce blu elettrica, che respirano nel vento.
Lanciano molecole di luce nel muscolo dell’aria, a destra e a sinistra, dietro
si chiude la strada come una coda fedele, che ci segue.
Davanti,
dannata e seducente la strada si rincorre tra le fiamme elettriche,
aprendosi nel varco dei nostri sguardi.
I nostri visi sono seri, i pensieri altrove ed attenti.
Il suono
ha oltrepassato la cecità, e si divincola intorno ai nostri corpi fermi.
Qualunque movimento è un elegante uragano in questa danza, ed ogni gesto resiste nel vento,
cercando invano e lentamente
la posizione di un’irrequieta scultura.
Le fiamme iridescenti scorrazzano nella nostra velocità, passano come istanti in fiamme, ed è un mai più in continuazione.
Ti giri di scatto mi guardi, mi sono appena girata anche io.
Nello stesso momento.
Un elegante tempesta, un sorriso, ci rigiriamo.
Non si sente niente.
Rientriamo nella strada e siamo immobili.
Non c’è più la vettura, non c’è più una strada.
Siamo davanti a
un’infinita distesa di strade tracciate da miliardi di colonne sottili, di vetro.
Inutile guardarsi.
La conosciamo già.
Mai stati.
Siamo a piedi nudi, sui piedi, dentro i piedi.
Mi prendi la mano e cominciamo a camminare.
Il pavimento è fatto di vetro.
Sembra.
Il cielo nero.
Vediamo bene.
La luce sembra arrivare da tutto ciò che ci circonda.
Pare pulsare ma è immobile. Un’infinta distesa di strade tracciate da colonne sottili come spilli.
Ma cosa c’è lassù, un’aquila. Vola lontana forte, ferma nella corrente di chissà quale fiato divino.
E’ bianca, volteggia,
ci guarda, continuiamo a camminare.
Ora è il suo volo ad essere assordante.
Ci aggiriamo in silenzio, in questo infinito spazio, i prismi sottili ci circondano con un ordine non simmetrico, deviando i nostri sguardi, sempre dritti.
Le mani si tengono forte.
Il passo coordinato, come quello di un cavallo con il cotone sotto agli zoccoli.
I nostri passi, le suole di cuoio, rimbombano secche ed elastiche, leggero e scatenato.
Ci muoviamo pianissimo, ma le colonne passano sempre più veloci.
Le mani forti,
cercano calore come una pianta in cantina.
Ci fermiamo, e le colonne continuano a passare, ora più lentamente, riusciamo a distinguere il loro passo, ed adattiamo il nostro per starci affianco.
Da questa stasi in movimento iniziamo a notare che le colonne sono formate da tanti cassetti
quanto la loro altezza infinita.
Ogni colonna finisce in un punto luminoso, lontanissimo, sembra un sole azzurro.
Al passo coi tempi, apriamo un cassetto.
All’interno vediamo file di lamine di vetro, perlopiù accatastate ordinatamente.
Alcune invece, sono rotte.
Ogni lastra quadrata ha un’enigmatica incisione sulla superficie.
Non riusciamo bene a distinguerne il tratto, e sono tutte completamente diverse tra loro.
Non una uguale all’altra.
Mentre continuiamo a camminare, cercando di decifrare l’arcano, i segni mutano sulla lastra.
Ad ogni respiro, inesorabilmente, si ricompongono.
Ma senza nemmeno il tempo di stupirci, sentiamo un rumore sordo, secco, elettrico.
Siamo ancora in cammino, per stare dietro al passo orizzontale delle colonne.
Lentamente sentiamo il suolo accelerare sotto i piedi.
Un impulso illumina il
soffitto di cielo nero assoluto.
Una scarica di fulmini orizzontali ci attraversa la strada, si dimena e contorce secca e lucente tra le colonne.
La bestia appare prima sulla nostra destra, come un’ombra.
Poi schizza rapida sulla sinistra, anche se, sembra muoversi molto lentamente.
Non ci dà il tempo di metterla a fuoco, e di nuovo riappare placida, tra le colonne.
Occupa rapidamente tutto il campo visivo.
Forse, sono due.
Sono due pantere, una bianca ed una nera, una la luce dell’ombra dell’altra, l’altra l’ombra della sua luce.
Iniziamo a camminare di nuovo, seguendo i balzi ottici delle due bestie.
Piano, laggiù vediamo l’orizzonte calare, e mentre tutto macina il suo sentiero, iniziamo a scendere una scala di vetro, che si dirama ad ogni piano.
Ogni scalino ha segni diversi, che mutano al nostro passaggio.
Seguiamo la pantera bianca e la pantera nera,
mentre loro
seguono noi.)
➶
(LA SPINA DORSALE
La prima immagine
L'incontro al fiume, sotto un albero di fico.
Con la sua foglia tenace, si appresta a coprirci dal nuovo sole, accecato nella sua stessa partenza.
Niente di più.
Niente di nuovo.
Come il dio, si trasforma.
Ci siamo davvero, sentiti?
Mi stai cercando anche tu.
O devo arrivare con una lunga ombra alle spalle ed aspettare il mezzogiorno insieme?
Mi domando davvero, se anche tu mi vedrai come la gazzella negli occhi del leone.
A prima vista.
Distogliere lo sguardo, è impossibile.
Semplicemente impossibile.
Il caldo è tutto
ad un tratto impermeabile. La polvere immobile.
Il battito velocissimo.
La lucertola deglutisce lontana, sulla pietra rovente.
Sbatte la palpebra dell’aquila
Là, un Nervo teso, sul picco.
L' hai vista anche tu? La foglia tremare.
Sì, inutile voltarsi.
Distogliere lo sguardo è impossibile.
Semplicemente, impossibile.
Profonda come il deserto, l'ultima lacrima, così densa, unica e caduta.
La polvere che sposta è tutto il movimento del tempo del mondo.
Come il dio, si trasforma.
Siamo già lì, soltanto pensandoci.
La dignità
di riconoscersi come partenza.
Quasi inutile andarci.
Ed è sullo scarto del quasi, che ci ritroviamo ad osservare la cangiante danza dell'orizzonte,
davanti a quel fiume, sotto quell'albero.
Nascosto nel frutto sanguigno, il silenzio del tuo mutamento.
Un segreto, quel fertile segreto.
Mi domando, se anche tu lo desideri, quel segreto.
Perché non lo sappiamo già.
Non esistiamo senza quel vecchio mistero, che
si svela inesorabile, sulla nostra pelle dorata.
Dopo questo lungo sguardo.
Verso quella lunga partenza.
Inizia davvero la marcia. La nostra marcia elegante, nell'oblio ignoto.
Il ritmo disteso, costante, inesorabile, come il mutamento.
Lo sguardo è unico, impossibile non inseguirlo.
Pensa se succedesse davvero, tutto, la gazzella con le narici aperte, lo sguardo attento che non vede ma ascolta.
Tutta la pelle che ascolta.
Anche l'aquila è immobile. Ma
il suo sguardo è un altro.
Spicca il volo, lo sentono tutti.
Senza voltarci.
Comincia a dosare il suo peso, scioglie le piume nell'aria, si districa nelle correnti, l'ala.
L’ ambra degli occhi si fa lucida. Trasparente.
La distesa
si ritrae sempre di più, sdraiandosi nelle sue più intime molecole.
Radici poi linee.
Serpenti neri.
Diventano piccoli punti, i primati avanzati.
L’umorismo sottile dell'auto elezione.
Direi che è una missione congiunta la nostra. Una co-operazione.
Non sarà una passeggiata, piuttosto
un'aguzza cavalcata, nelle ombre e nei confini.
La lucertola deglutisce.
Lontana sulla pietra bollente.
Anche la nostra pelle trema.
Con gli occhi negli occhi.
Anche tu sei l'unico a non vederti negli occhi, l'unico proprio come me.
Mi domando a volte anche se siamo alla stessa distanza dall’albero.
Agli antipodi.
O se siamo invece
già molto vicini, quasi da guardare nella stessa direzione.
Come sarebbe allora, poi, guardarci negli occhi.
La pelle e gli occhi che, come acqua trasparente, sono mandorle attente.
Si trasforma anche il movimento, negli occhi dell'aquila.
Sempre più su, noi sempre più giù, da lassù, ci siamo quasi incontrati.
L’impenetrabile scarto del quasi, ancora.
Il vento cambia calore, sempre più su, il serpente trasparente continua a navigare.
Il battito è velocissimo.
Immobile resta, e vede d'un tratto, la foglia tremare.
L’abbiamo vista tutti, senza voltarci.
Forse il leone no.
Il becco punta la foglia, da lassù, in altissimo.
Ma vede dietro alla foglia, ancora più giù.
Vede una traccia nella sabbia, una traccia fugace, sinuosa, veloce.
Mi è sembrato di vedere un leggero bagliore nell'artiglio sospeso.
Il cammino è sostenuto, lento, inesorabile.
La picchiata grida diritta.
Il serpente invisibile del vento è tranciato dalla tua caduta libera.
Non esiste più la possibilità di essere memoria.
È solo adesso, che
sto cadendo verso di te.
Velocemente.
E le linee diventano montagne, e le montagne diventano pietre ed arbusti, le pietre diventano sabbia e gli arbusti foglie, e
la traccia sula sabbia entra nell'iride dell'aquila.
Non voglio quasi che sia già adesso, ma lo è, sto cadendo velocissima verso la nostra più dolce memoria.
La nostra prima immagine.
Mi guardi con le braccia aperte, le mani grandi, stai cadendo velocissimo, stai cadendo velocissimo, verso di me.
Il frutto ignaro, continua a crescere.
Prosegue.
Come il dio, muta.
E questo istante immenso che ci separa è la più rara verità dell’esistenza,
una sorgente d'acqua, la più morbida tregua alla nostra più agguerrita battaglia.
L'ultima lacrima nel deserto l'ha lasciata il serpente nero, che si dimena ora nel cielo, abbracciato dall'artiglio sospeso che non guarda ma sente.
In volo
ha pianto un canto, una preghiera, un buon auspicio.
Ha cantato di quella pioggia, che un giorno fece fiorire la sabbia, che un giorno farà fiorire la sabbia.
Ha pianto la prima goccia, del miracolo sacro, dell’umidità, come corpo a contatto,
l’invisibile spazio della lacrima. Ma la lacrima del serpente
non raggiungerà subito la terra ardente.
Incontra la foglia e con sbalzo di inerzia, ci rimbalza sopra.
E si mette comoda,
riassestando l’orizzonte.
Avremo tempo di berla anche noi, giusto il tempo, per bagnarci le labbra, dopo il nostro lungo cammino.
Chissà come sarà la nostra traccia. L’ incontro delle nostre due colonne vertebrali.
La più intima luce e la più profonda ombra del vivente.)
➶
(LA GOLA
Un’
eco.
La cisterna.
Noi.
La parola del
Fu e Sarà, due amanti antichi.
E lo spazio dell’aria.
La voce.
Il fantasma non si aspetta di essere invitato.
Il fantasma si presenta.
Nello spazio tra le parole.
Il fantasma non lascia inchiostro altro che la sua
immanente presenza.
Si mostra,
lascia il linguaggio
senza fiato.
Fresco entra,
caldo esce,
il vento della voce.
Assordante
il vuoto di quella distanza,
il
cielo tra le cose.
Il tutto che si immerge nel vivente,
immenso
e dal vivente raccoglie il calore delle sue viscere
per darlo
con un soffio al cielo.
Mentre qualcuno là dentro mormora:
I am an exhibition of scars.)
➶
(GLI OCCHI
La pelle del giaguaro si allunga sinuosamente alla fine della notte.
Ogni nuvola piange una lacrima che si trasforma in un torrente.
La terra muta in fango e poi inizia a fluire.
Ma ad un certo punto ricevo
un vento freddo, caldo, poi freddo e, alla fine, abbastanza freddo.
Mi addormento.
Il piccolo dio si spoglia, tremando.
Cerca nel buio freddo con la sua minuscola mano, finché
non trova la pelle dell'enorme giaguaro.
Calda e immensa fino ad essere
anche lontana.
Disegna a sé il grande mantello e si rannicchia nel cielo.
Sotto di lui, il grande disco ultramarino brilla di rugiada e si addormenta.
Non appena il frammento del dio inizia a sognare,
la bestia gigante riprende a camminare,
con il giovane maestro
tra le scapole.
Lungo il
sentiero celeste,
la grande ombra luminosa
raggiunge una foresta di alti alberi, bianchi e fini.
Una distesa di antenne.
Il lento giaguaro, il passo felpato, cammina lento,
attento con un orecchio
al respiro addormentato tra le sue scapole.
L’altro orecchio è ormai annientato, inebriato, perduto,
insegue
un ronzio diffuso,
che lo attrae e lo abbandona, fugace come l’animo tra due parole.
Segue il moto dei corpuscoli di questo suono, perde la direzione,
si lascia trasportare lento e tranquillo dalle onde di questa vicinanza
e poi di questa
incolmabile distanza.
Le longilinee costruzioni sono quasi trasparenti, se non per i tanti riflessi che qua e là si agitano iridescenti sulle pareti delle antenne.
Un’ombra offusca il cielo, e tutto diventa nero per un’istante.
Fu proprio in quell’istante d’ombra che il piccolo dio si svegliò.
Le palpebre
allarmate della loro inefficacia si dilatano immense.
Il giaguaro inspira dalle narici, il buio a perdita d’occhio.
Un urlo
squarcia il cielo.
La luce acceca il silenzio.
Il dio dell’acqua comincia a piangere mille fontane.
Le antenne cominciano a vibrare.
Un corto circuito
divampante.
L’acqua piove sulle membra elettriche delle costruzioni.
In ogni goccia che cade, una minuta riflessione.
L’iridescenza,
diventa incandescente.
Poi, bianco.
Macchie di luce bruciante si alternano a macchie di buio assoluto.
La cornea del bambino, ormai irradiata di gocce di puro sale, riflette tutto il grande disco ultramarino.
Non vede più altro che la pelle del giaguaro, lampeggiante,
a perdita d’occhio.
Come un fosfene che marcia candido nella sua stessa illusione,
che
si riflette nella sua stessa concezione.
Una macchia dopo l’altra, impossibile da afferrare.
Sopra di lui, intanto,
ignaro, il grande disco ultramarino brilla di rugiada
e si sveglia. )
➶
(IL VIRUS
Il virus si muove come il pensiero.
Piacere di rivederti, dinosauro.
È passato tanto tempo da quando ci siamo visti l’ultima volta.
Che
eleganza, caspita.
Ma cosa ti è successo, sei un altro.
Hai incontrato il nervo vago, anche tu.
Continuamente.
In effetti anche io ho sentito la voce di qualcuno, lassù, alla cisterna.
Un canto, quasi.
È un sentiero pieno di bestie, là fuori, amico mio.
Si, anche io ho sete, andiamo.
Avanti,
solo avanti.
E cosi arriva, sinuoso e letale.
Letargico poi bestiale.
Nel dubbio stesso della sua assenza, che
giace intricato nella certezza della sua presenza.
Le cellule induriscono i propri confini, ma lo spiraglio rimane aperto.
Per entrare, incorporare, convertire e poi uscire, proseguire.
Una mimesi forzata, quasi militare, strategica.
Si muove nel codice genetico, si incastona nelle sue catene.
E muta, come il dio muta.
Duello e riconoscimento.
Si insinua, come il dubbio.
Morde la fede nell’anima sua più nascosta.
Ne penetra i confini, ne abita le stanze.
La bestia si muove a suo agio, corridoio dopo corridoio, si fa strada sagace, disinvolta, sveglia.
Con la calma degli angeli più alti, si accomoda al focolare, si guarda intorno con
fare familiare.
Sorride. Converte le regole, divora i riti, innalza nuovi canti, marcia come una fiamma, un pensiero veloce.
Convince,
innatamente.
E silenzioso muta, come il dio muta.
Insieme al suo passaggio.
Le stanze come specchi troppo caldi cominciano a gocciolare in laghi affranti, e poi di nuovo specchi.
So modellare gli specchi, ho imparato da mio nonno.
La bestia scende i sentieri più intimi, sorridendo,
ammaliando.
Digerisce mangiando, inarrestabile,
inesorabile.
E tutto muta, come il dio muta.
Ma, d’un tratto e da sempre, come in tutte le cose, esplode l’adattamento.
Bestia ancor più vorace, empatica, veloce.
Giovane, in corsa, territoriale, ignaro.
Sorridendo anche questa bestia si muove per le piazze, tra pacche sulle spalle ed un sorriso all’arrivo della pioggia.
Si accomoda al
focolare e si guarda intorno con fare familiare.
Affamata.
Esiste la forza senza la resistenza?
Ed è allora in quel mutamento che la resistenza, come forza vitale,
crea il nuovo immunoreale.
E non si ferma mai, iniettando il conforto del riconoscimento,
ottenendone una immediata diatriba in risposta, enigmatica, veloce, specifica, effimera.
Perché muta, come il dio muta.
Ed è proprio in quella danza, tra le due bestie e la loro mimesi,
che si nasconde silenziosa la verità del mostro.
Il pensiero è come il virus. Il mostro sono io.
E io e il dio e io e il dio ed io e il dio e l’io e dio… )
➶
(LE VISCERE
Fu così che il grande dio iniziò ad organizzare le sue sabbie in mille soli, distribuiti in modo geometrico,
creando spazio per mille miliardi di miliardi di specchi.
Bentornato dinosauro.
Ho saputo che nell’altra fine del mondo, i fiati comunicano ai flussi l’intorno immanente,
e lo portano fedele a tutto ciò che mai è assopito,
all’ombra della pelle.
In questa leggera brezza tiepida, gli organi stanno, come tante hamac, letti pensili in fervida meditazione.
Intorno guardiani d’avorio, e fasci di muscoli tesi, cha camminano verso l’albero di fico.
È quasi tempo.
È quasi tempo.
Il tempio.
Composizione e strategia dei ribelli alleati.
Nella grande corte calda, gli organi
filosofeggiano all’ombra, decomponendo il mondo in atomi.
Una base attiva e silente, sotterranea, sommersa, sospesa.
Ascoltano le parole del vento, che viaggia nel mondo, e
riporta presenti.
Sulle amache riposa un gruppo di vecchi lupi di mare,
nati come grappoli dalla stessa madre,
cresciuti all’ombra verticale del mezzogiorno e da subito in azione
tra stelle e sussulti, sparpagliati e compatti,
fino alla fine del tempo.
Un oceano di molecole operaie. Le viscere.
Alleati, gli organi si devono organizzare.
Intanto il pensiero
ruggisce, laggiù. Si agita, si dimena. Ama.
Le molecole della terra si sbriciolano in atomi i danza.
Respira il sangue, respira nutrito, ignaro.
Vi parlo con una matita in mano, dal pianeta blu smeraldo.
La postazione di due gechi sopra la finestra brilla di luce intensa.
Un
magnete li tiene fermi.
Suona come una colonna d'oro, ed è enorme, come un sole feroce.
Così silenziosamente entra una libellula rossa.
(Apro un po' gli occhi, il pianeta è tranquillo…).
La libellula guarda senza fretta.
Seduce la conoscenza dell'anima, rosicchia l'involucro della noce più intima,
non prima di invadere lo spazio con la sua grazia morbida.
Ma torniamo al magnete. Vediamo cosa succede, e se andrà tutto bene in questo pomeriggio fresco e limpido.
Al suono della brezza, ad un certo punto della loro vita, i gechi iniziano a sentire una fame necessaria ed improvvisa.
Una
visione futuristica.
Un limbo statico, un intestino. I quattro occhi tutti diversi orbitano tutt'intorno.
L'estrema immobilità collega l'orientamento e il suo oggetto goloso:
la direzione.
Con la balistica dell'attacco ormai raffinata, manca solo una cosa: la preda.
Come sangue in una danza incarnata le due bestie vibrano impercettibilmente.
A metà giornata, la libellula si impone senza ombra, senza margine, tra le otto gambe agili.
Ma quando il sole non ha ancora rimosso
le ciglia dal mezzogiorno,
all’alba delle prime ombre, la pelle trasparente riflette la danza del giorno.
E si muove rara come qualsiasi futuro.
Il gioco di luce stordisce i quattro occhi attenti.
Un'illusione poderosa, cangiante, viva come il sangue.
(Apro gli occhi un momento e sono qui, e siamo qui, in questa sottile tempesta di fuoco).
In questo cortile estremamente presente che sembra un tempio di adrenalina, troviamo che manca una cosa:
la preda.
Proprio così come è entrata, la creatura rossa si è alzata in verticale, senza emettere suono.
Liquefacendosi come una lacrima. Esce in silenzio.
Le gole, bruciate dalla sete, si guardano
sorridendo.)
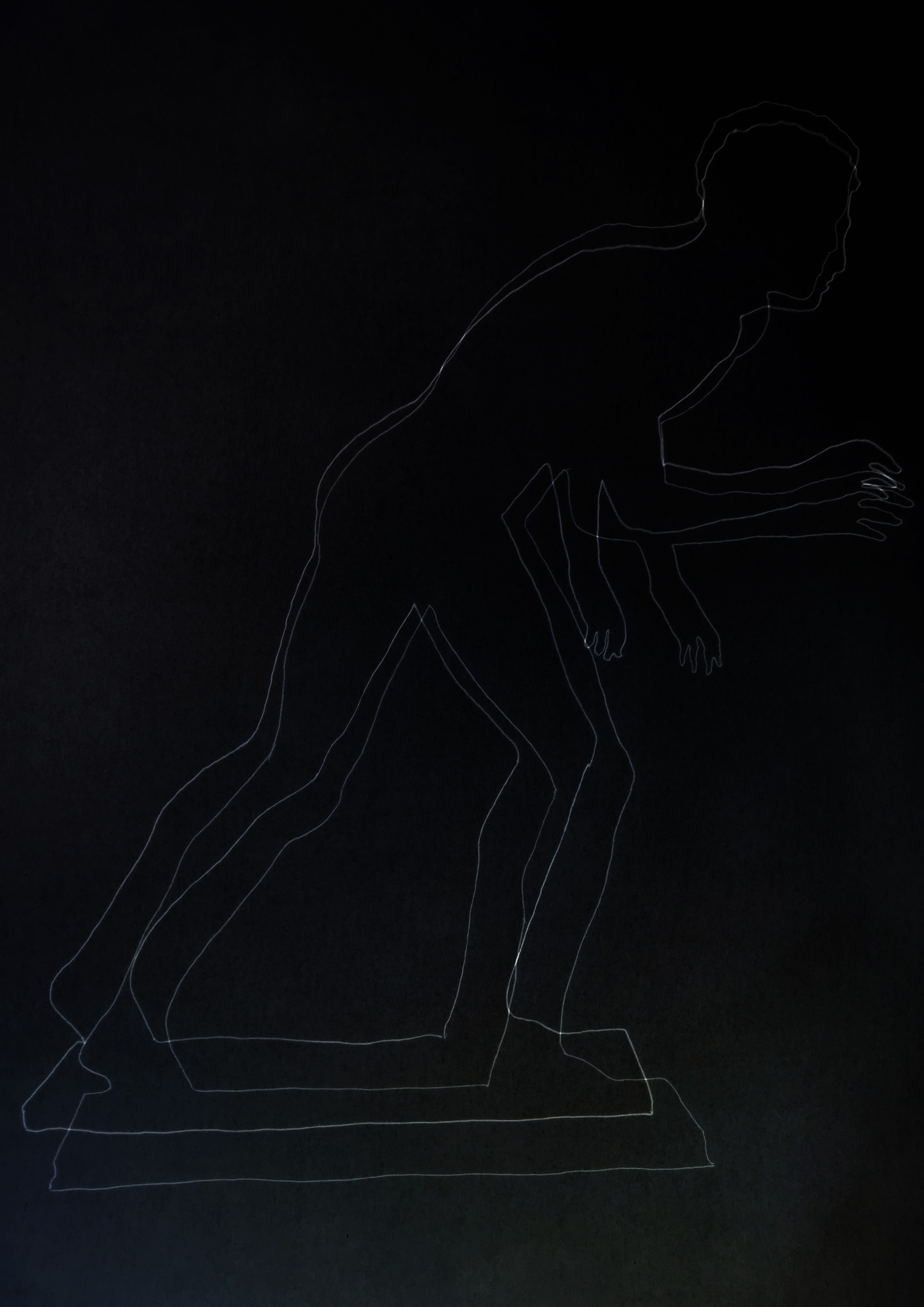 MAIN MENU
MAIN MENU